Publicado en la revista italiana NIM (www.nimmagazine.it)

Il fascismo promosse fondamentalmente gli sport di squadra perché considerava come società esemplare quella in cui l'individuo viene sempre dopo il collettivo, questo al contrario del nazismo che incentrava la sua retorica sulla superiorità e purezza razziale. Mussolini, seguace di Le Bon, pensava il calcio come dimostrazione e riflesso della disciplina e dell'unione dell'Italia fascista, tuttavia i fatti di cronaca ci rivelano il persistente, conflittuale, spirito campanilistico; di fronte al tentativo di trasformazione del corpo, la psiche ed i comportamenti attraverso la diffusione del calcio e l'educazione fisica, i tifosi costringevano alla sospensione delle partite per scontri, come quelli della finale scudetto del 1925 tra Bologna e Genoa, che si giocò 5 volte, l'ultima delle quali a porte chiuse. Mentre il fascismo promuoveva la vittoria di squadra, tra le altre cose perché le immagini dei campioni non rivaleggiassero con quella del Duce, i tifosi fomentavano il proprio mutuo odio, fatto che spinse Mussolini a chiedere ufficialmente aiuto ai giornalisti per raggiungere la desiderata unità. «Oggi il giornalismo sportivo è una forza attiva e vivente nel regno del fascismo e deve necessariamente essere all'altezza della propria missione» recita il decreto 29/1929, ed è con questo spirito che nascono i molti quotidiani e settimanali sportivi dell'epoca: La Gazzetta dello Sport, Lo Sport Fascista, Il Calcio Illustrato, La Vita Sportiva ecc.
Martin ci racconta come in Inghilterra, Francia e Germania fu la nobiltà a formare le prime organizzazioni sportive come simbolo di evoluzione della forza dell'individuo. In questo senso De Coubertin vedeva nel pubblico un elemento contingente, attribuendo al superamento personale il vero significato dello sport. Tuttavia esisteva un'altra visione, già presente nell'Olimpiade parigina del 1900. Una volta che questa fu inclusa nell'Esposizione Universale, De Coubertin fu significativamente estromesso dall'organizzazione, con la ragione che i Giochi rispondevano in quel caso a una visione borghese dello sport, che intendeva l'Olimpiade come spettacolo dell'evoluzione umana. È quest'ultima prospettiva che si afferma in Italia, dove le prime organizzazioni sportive furono appunto fondate da borghesi e si basavano nel gusto per l'osservazione invece che per il culto del superamento personale – anche per via del fatto che in Italia l'unico individuo riconosciuto in quanto tale doveva essere Mussolini.
A riprova di queste tesi Martin descrive come l'architettura futurista avesse come riferimento per la progettazione degli impianti sportivi la massa degli spettatori e, dunque, lo spettacolo. Barbero, uno degli architetti protagonisti della rivista Quadrante, affermava: «L'architettura sportiva futurista si occupa dello sport come spettacolo, funziona per l'evento sportivo e per la folla del pubblico». Tuttavia l'architettura veniva utilizzata con un duplice obiettivo, apparentemente contraddittorio: da un lato si voleva recuperare il classicismo romano e greco e, con questo, la grandezza imperiale; dall'altro si cercava di creare, mediante una concezione moderna, un luogo per “sviluppare la cultura fisica del collettivo in maniera più accurata, ordinandolo in modo da ottenere maggior efficienza e da formare una nuova mentalità» (p. 116). Questa apparente incompatibilità tra architettura antica e futurista scompariva nella prospettiva dei grandi architetti del fascismo come, ad esempio, Marcello Piacentini, che descriveva lo Stadio del PNF, sua grande opera, come un «antico gimnasium modernizzato».
Martin, che si inserisce nella migliore tradizione dei cultural studies, descrive con dovizia di particolari molti altri aspetti del fenomeno, ma quello che ci interessava sottolineare in questa sede è come il libro permetta di osservare lo sviluppo del calcio italiano come sport-spettacolo, sempre legato a un gusto di alto contenuto politico tipico della figura mussoliniana, secondo cui già Giovanni Pisano, nel XIIIº secolo, pensava al fascismo nel momento in cui collocava un'aquila nel pulpito del Battistero di Pisa.
Simon Martin è ricercatore alla British School of Rome. Calcio e fascismo ha ricevuto il Lord Aberdare Literary Prize for Sports History nel 2005.
© Rayco González 2007












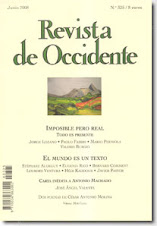



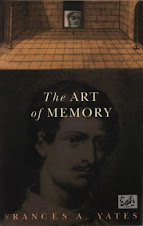







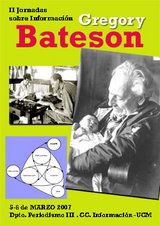

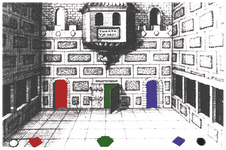
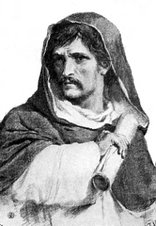
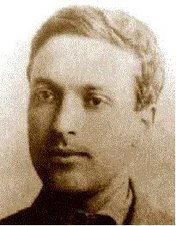


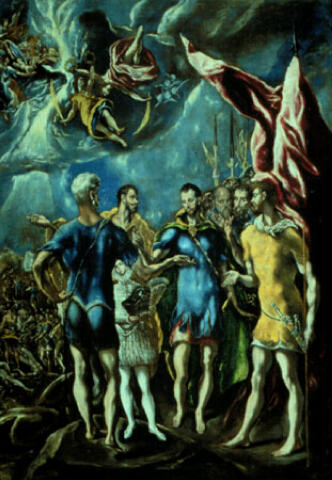

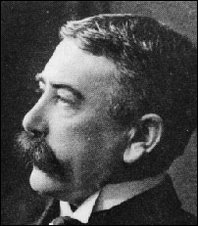

No hay comentarios:
Publicar un comentario