Dire non è mostrare
L. Wittgenstein
Prima di cominciare, vorrei chiarire che il mio approccio alla problematica della politica sarà dal punto di vista esclusivamente semiotico... Sì, semiotico... La semiotica, secondo Eco, è quella disciplina che studia tutto ciò che può essere utilizzato per mentire... dopo tanti anni di studio ci siamo resi conto che tante sono le menzogne quante nel mondo sono le cose. Le cose non sono determinate per loro stesse, ma per il loro utilizzo... La politica, ad esempio, può servire come velo per coprire o nascondere reati: quindi non mi sembra questo un ambito estraneo alla semiotica... La possibile differenza fra la semiotica e la politica consiste nel fatto che mentre la prima studia tutto ciò che può servire per mentire con lo scopo di capire ed eventualmente scoprire le menzogne, la politica lo studia con lo scopo di fabbricarle!!!
Permettetemi una sfumattura semiotica vincolata indirettamente a questa nobile città su questo argomento. Dopo la Babele visiva delle torri, la guerra si è fatta nel segreto. Il prof. Paolo Fabbri direbbe che dopo la guerra fredda, la guerra stessa si fa all’ombra. Nell’Antichità, Hermes proteggeva i ladri: quello era un mondo dove la guerra instillava una comunicazione irriducibile a quella del pacifico consenso. Ma cosa accade quando, nel mondo globale di oggi, i segni diventano indizi e i discorsi delazioni?
La figura fondamentale nascosta —ma facilmente riconoscibile— sotto quell’ombra è quella della spia. La spia è la figura del doppio gioco, di quel personaggio a cui si è disposti a credere, anche se, in certi casi —come vedremo—, il suo doppio gioco non permetterebbe l’esistenza della fiducia verso di lei... In effetti, quella mancanza di fiducia ha provocato una cattiva immagine della figura della spia, fino al punto che oggi, addirittura, lo spionaggio si nomina sotto certi tipi di eufemismi, come ad esempio “agente segreto” o “servizi segreti” o “speciali”. Ovviamente la spia lavora sulla figura del segreto, figura che nella semiotica definiamo come quello che non sembra vero ma di fatto lo è (a differenza della menzogna, cioè quello che sembra vero ma di fatto non lo è). La spia sa che in ogni momento la sua vita è in pericolo, motivo per il quale bisogna capire con quasi assoluta certezza le reti della società. Non voglio sorprendere nessuno ammettendo la mia ammirazione per i grandi criminali della storia: soltanto lo sviluppo di una grande conoscenza della realtà sociale può permettere loro di fuggire dalla legge. Figure come quella di Andreotti dovrebbero essere analizzate profondamente per una miglior comprensione della nostra società.
La loro mancanza di dignità —parlo ancora delle spie— si manifesta poi nella figura dell’agente doppio. La spia è sempre pronta a trasformare la complicità in complotti, eppure esiste una fiducia da parte almeno dei governi, di coloro che detengono il potere.
La parola spia deriva direttamente dalla radice indoeuropea “pek”, “guardare con attenzione” e ci da tra l’altro parole come “specchio” o “spettacolo”: “specchio” rinvia alle apparenze della realtà (sdoppiamento, “espejismo” —in spagnolo—, miraggio, illusione) mentre “spettacolo” rinvia alla posizione della spia come spettatore diretto di una scena concreta, ma anche come attore partecipante all’azione stessa. La spia intende ottenere informazioni sia recitando il ruolo dello spettatore sia cercando di non essere scoperto mentre partecipa alla situazione in veste di attore (segreto).
Possiamo prendere un altro esempio da Watzlawick. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo britanico inviò due spie in Francia. Per motivi di sicurezza, a nessuna delle spie si comunicò la presenza dell’altra nella stessa nave durante il viaggio al continente, per diminuire i rischi: se c’era una spia nemica, e loro agivano in complicità, quella poteva scoprire la loro identità. Purtroppo ambedue hanno sospettato del altro... Questo esempio serve per capire la situazione ambigua delle spie (dentro = attore vs. fuori = spettatore): la loro capacità d’identificare l’altro dimostra anche il ruolo speciale della spia dentro l’interazione.
Senza voler essere polemico, nella politica accade una cosa simile. Al di là della preoccupazione suggeritami dalla situazione della politica attuale dove non esistono più i politici, quelli che vengono chiamati politici giocano in modo simile alle spie: i segni diventano esclusivamente indizi. La mancanza di fiducia verso i politici si potrebbe esplicitare facendo una battuta facile: mentre prima si parlava del politicamente scorretto, oggi possiamo parlare dello scorrettamente politico... La politica è il luogo dell’opportunismo, degli interessi oltre la politica. Nessuno mette in dubbio che oggi i politici abbiano interessi al di là della politica. Alcuni premier sono infatti imprenditori, i cui interessi forse non sono volti al bene comune o alla comunità...
Qui dovremmo far riferimento all’opera di Michel Foucault, Sorvegliare e punire, dove il filosofo francese ci ricorda chiaramente che la politica, come tecnica di pace ed ordine interiori, è stata concepita come continuazione, se non direttamente ed esattamente della guerra, almeno del modello militare come mezzo fondamentale per prevenire i problemi civili (sic): la strategia è quella dell’esercito perfetto!!
Ancora Fabbri dimostra che certe parole molto utilizzate da parte dei politici rientrano nello scorrettamente politico: audience, clandestino, competitività, demonizzazione, devolution, flessibilità, guerra, kamikaze, odio, terrorista, vincente, zero tolleranza ecc. Addirittura possiamo aggiungere “integrazione”, una delle parole più brutte che abbia mai sentito!!
Chiedamoci prima di portare avanti il nostro discorso cosa vuol dire “corretto”. La sua rete lessicale inizia nella parola “diritto”, che significa non soltanto tutto ciò che è legato alle leggi, ma sul piano fisico movimento rettilineo e sul piano morale un modo coerente e retto di comportarsi. Da qui derivano parole —molto indicative tra l’altro— come “regime” o “rogatoria”. Lo scorretto è la traccia visibile del condannabile: gli indizi soltanto possono esistere in una società dello shock quando si è in grado di interpretare un’azione fuori dal regime, dal retto, cioè il caos, il disordine e quindi l’insicurezza. Non dimenticare che, come ci ha mostrato il vecchio McLuhan in un articolo pubblicato negli anni sessanta, la comparsa della letteratura rinascimentale nel cinquecento e quella del romanzo poliziesco nell’ottocento si deve fondamentalmente allo scontento dovuto all’alienazione dell’uomo, che emerge dalla repentina scomparsa dei riferimenti economici e politici. McLuhan si riferisce a due figure di certa somiglianza: quella del superuomo del Rinascimento e quella del detective dell’ottocento: “in periodi d’insicurezza e di disordine pubblico —ci dice—, le tendenze umane ordinarie verso l’emulazione o l’occultamento aumentano: sia per farsi individualmente invulnerabile sapendo e avendo tutto, sia imparando a risolverle”. Queste figure, conclude McLuhan, ci hanno dato un’apparente sollievo alla sensazione d’insicurezza a cui faceva riferimento: il referente rinascimentale era quello del saggio capace di saperi quasi illimitati, tipo Leonardo, altrettanto succede col detective romanzesco nell’ottocento la cui saggezza enciclopedica gli permette di controllare i segni della realtà e quindi i momenti d’insicurezza.
Nella mia vita mi sono interessato soprattutto ai meccanismi che permettono di far comparire il sospetto davanti a certe situazioni: una delle prime cose che compare è sempre l’idea dell’evidente... L’evidente è tutto ciò che si presenta chiaro agli occhi. Il problema è che la presenza di un segno di qualcosa non è per forza una prova giustificante dell’esistenza di qualcosa d’altro (aliquid pro aliquo, definizione classica dei stoici): il fumo non sempre stà per il fuoco, anche se si presenta come un’evidenza della co-presenza del fuoco: può darsi che qualcuno abbia fabbricato quel fumo grazie a una macchina (sempre restano da scoprire le sue motivazioni...) Nella politica, l’unica evidenza chiara è quella del doppio gioco... Come la spia, il politico mostra un’immagine evidente di un atteggiamento giusto ed adeguato al suo ruolo istituzionale. Non credo che gli esseri che abitano la politica odierna siano tanto diversi di quelli descritti da Machiavelli. Ma uno dei problemi dei politici di oggi, a differenza di quelli del passato, è che si è istituito un regime di ‘sospettabilità’ —permettetemi questa parolaccia...— fra cittadini e classe politica: i politici hanno imprese, interessi in conflitto che si mostrano come una macchia davanti ai cittadini.
Prendiamo un esempio che può chiarire molte cose. Tutti abbiamo avuto a volte una relazione sentimentale nella nostra vita (maledetti!!). E tutti sappiamo benissimo che a volte la gelosia è la più brutta di tutte le passioni, poichè, come diceva Spinoza, suppone la valutazione dell’altra persona in rapporto con te stesso. Comunque quando questa seccante malattia serve da filtro della realtà si stabilisce un rapporto di sospettabilità in cui ogni segno diventa indizio di tradimento, anche nel grado zero degli indizi, cioè l’inesistenza dei propri e veri indizi. Per capirci, quando si scopre un indizio questo diventa una riaffermazione del sistema stesso basato sul modello di sospettabilità: “ah, lo sapevo... ma cosa posso fare, lei mi vuole bene ed alla fine ha riconosciuto il suo errore...” Non ci basta altro che ricordare la storia di M Swann, chi si sposò con un’attrice —poverino... infelice idea!—: quando scopre il tradimento da parte di Odette, Swann non rompe la sua fiducia totalmente, poiché ambedue sanno benissimo che il loro rapporto si basa sui solidi fondamenti del sospetto. L’unica maniera di arrivare alla rottura totale della fiducia, e quindi acquisire un rapporto di sfiducia, è quello del passaggio dalla fiducia piena alla sfiducia... In quel momento, un indizio può servire a mettere in funzionamento il complesso gioco del conflitto sociale.
Per essere rilevante, un indizio dev’essere inteso come involontario. Se invece l’indizio è capito da chi lo percepisce come una confidenza —cioè come un atto volontario di svelamento— o come confessione —sia come atto volontario sia come atto forzato dall’interlocutore—, sempre saranno in dubbio le possibili motivazioni che hanno provocato un’azione del genere. L’involontarietà del indizio svela quello che di solito chiamamo sintomo, molto vicino all’idea di serendipity.
Mettiamo un altro esempio: 13 marzo di 2004, a Madrid. Due giorni dopo l’attacco contro la stazione di Atocha, il governo di Aznar afferma ancora che molto probabilmente gli esecutori dell’attentato sono stati i membri dell’ETA, mentre i giornali di tutto il mondo parlano di Al-Qaeda... Il giorno seguente il popolo spagnolo elegge i suoi rappresentanti in parlamento: le due informazioni contrastanti mettono in dubbio l’atteggiamento del governo e lasciano una traccia, cioè un indizio, dei probabili interessi del Partido Popular... e dunque la popolazione manifestò contro il governo in forma espontanea. Il problema dell’indizio è che, mentre si prende come base dell’interpretazione, si scarta sempre la co-presenza della prova. In effetti, come ha dimostrato il mio maestro Carlo Ginzburg, al livello del paradigma indiziario —o modello congetturale— soltanto possiamo parlare di un istinto basso e alto: il primo sarebbe legato a un paradigma usato per elaborare forme di controllo sociale sempre più sottile e capillare mentre il secondo sarebbe legato all’utilizzo più “scientifico” fatto dagli studi umanistici. Per arrivare ad un istinto alto secondo Ginzburg bisogna esaminare i particolari più trascurabili. Ecco la differenza fra alto e basso istinto: il tipo d’esame, cioè l’analisi.
Il sospetto verso i politici si basa dunque sull’impossibilità della prova e sulla presenza degli indizi come centro delle interpretazioni dei cittadini. Certe mosse politiche compaiono come un’attività sospettabile. Ancora un esempio: Eric Besson, dirigente del Partito Socialista francese, è passato dalla militanza socialista al governo di Sarkozy, dopo aver organizzato la campagna anti-Sarkozy. In un’intervista fatta dalla rivista francese Le Point il 30 di maggio scorso, Besson dichiarava: “Non ho tradito. Non ho tradito né le mie concezioni né il mio paese. Secondo me, il PS è stato uno strumento di trasformazione sociale. Non è stato «la mia famiglia» né «il mio campo». Il mio campo è la Francia. Il mio campo è il miglioramento della vita quotidiana dei francesi. Oggi penso che è il PS chi ha tradito le concezioni che avevano giustificato la mia adesione. Io avevo aderito a un partito progressista che aborriva il culto alla personalità. Dandosi a Ségolène Royale, il PS ha tradito la sua storia e i suoi valori”. Tutto ciò che Besson ha detto per giustificare il suo abbandono del PS può essere condiviso senza obiezione; il problema ci si presenta quando sotto questo discorso di difesa dei valori politici si nasconde un segno politico che diventa un indizio: Besson forma parte del governo di Sarkozy, un uomo politico che ha sfruttato la sua megalomania, cioè una figura politica che non c’entra nulla da vedere con i valori che secondo Besson sono i motivi della sua attività politica.
Il rapporto con l’analisi barthesiana sul discorso di Pierre Poujade, famoso uomo di politica francese che, dopo aver passato effimeramente dentro delle giuventù vichystes, collaborò con la Resistenza francese via Spagna. Barthes osservava che nel discorso di Poujade comparivano elementi d’identificazione tra la Francia —come idea mitica di un popolo, il francese— e la politica di destra: tutto ciò che fa la destra è quello che vogliono i francesi, o la destra non fa politica mentre la sinistra fa politica —lì dove si dice politica dobbiamo capire partito. Nella politica, anche se sembra un pò bizarro, la costruzione di miti è ormai alla base di tutti i partiti.
Claude Lévi-Strauss —permettetemi anche questo omaggio al più grande intelettuale ancora vivo— descrive le operazioni mitiche nel capitolo «La scienza dello concreto», del suo capolavoro Il pensiero selvaggio, —cito a memoria— come l’organizzazione del mondo (il discorso mitico) che, senza possedere principi scientifici, riesce ad avere un’efficacia intrinseca grazie alla messa in struttura di elementi eterocliti, cioè contrastanti. Prendiamo un esempio classico da Lévi-Strauss: gli indiani osago classificano l’aquila come un animale terrestre. Il percorso semantico sarebbe: l’aquila vola come il fulmine, il fulmine crea il fuoco, il fuoco è prodotto dal carbone e quindi l’aquila è uno dei padroni del carbone, essendo per tanto un animale terrestre. Non voglio dire che Sarkozy sia un animale —a differenza delle aquile senza piume— e neanche legarlo alla figura simbolica dell’aquila —ci mancherebbe!—, dico soltanto che vincolare Sarkozy a valori come «miglioramento della vita quotidiana» o «umiltà» (per opposizione a «culto della personalità») mi sembra molto vicino alla rappresentazione del mondo dai miti osago. Come semiologo non posso rientrare in un’analisi genetica del legame esistente tra gli osago e i francesi, ma andarebbe —a mio avviso— analizzato con grande successo!!
Non condivido molto l’idea benjaminiana d’identificazione tra capitalismo e religione, soprattutto perchè ritengo che la preghiera ed il rito sacro sono gli elementi che ci permettono di parlare di religione. Invece credo che i discorsi mitici della politica hanno la funzione di schermo, di sdoppiamento o “miraggio” dell’attività politica. È palese l’invito che fanno questi discorsi a sospettare... ma il problema è che la sfiducia e il sospetto hanno un rapporto semantico assimetrico, cioè il sospetto include necessariamente la sfiducia (senza sfiducia non può darsi il sospetto) mentre la sfiducia non include per necessità il sospetto. Ritornando al esempio delle coppie, se io ho stabilito un rapporto di fiducia con la mia ragazza e trovo un indizio o una prova di tradimento, quel indizio o quella prova supporrà la rottura della fiducia: l’indizio stesso o la prova stessa sono la negazione del modello stesso di rapporto.
Quindi nell’attuale situazione di sospettabilità verso i politici, la possibilità che si dia un movimento sociale di rottura contro le strutture politiche è quasi nulla... Tutto ciò vuol dire che soltanto ritornando a un modello di fiducia nel rapporto politici-cittadini si potrà eventualmente produrre un movimento di rivolta che non affoghi nel momento esatto della sua emergenza... E chi può assegnare i politici come giusti destinatari di fiducia? Ovviamente non possono essere i stessi politici —voi sapete benissimo che nessun italiano intelligente (parlo soltanto ipoteticamente...) si fiderebbe di Berlusconi anche se Prodi ci dicesse quanto affidabile è Silvio...
La mia critica può sembrare molto vicina a quella che Georges Sorel indirizzò a Jean Jaurès in tantissimi articoli: Sorel criticava il fatto che Jaurès abbia abbandonato la lotta nelle strade con gli operai per rientrare pienamente nella vita politica borghese partecipando all’elezioni e essendo rappresentante socialista nel parlamento. Per niente. La mia critica suppone un tentativo di capire meglio cosa accade in un mondo dove i segni diventano indizi e i discorsi delazioni, come ho detto all’inizio.
Goffman diceva che non esistono “gli uomini e i loro momenti” ma “i momenti e i loro uomini”: ugualmente ogni cultura definisce dalle sue caratteristiche gli atteggiamenti degli uomini. In effetti anche noi i semiotici definiamo la cultura come atteggiamento verso il segno. E quindi in un mondo dove i media ci costringono a una lotta d’informazione fra i politici nel grado zero dell’indizio (Collin Powell, ad esempio, affermava testardamente avere prove —e non indizi— del possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein: quante volte abbiamo sentito affermare l’esistenza delle armi irachene da quel momento?), tutto discorso fatto dalla struttura politica diventa una delazione delle vere motivazioni dei politici: interessi personali, acquisto del potere... L’atteggiamento dei cittadini è chiaro: per loro i politici nascondono interessi sospetti...
Lasciatemi finire con una disquisizione etimologica verso il futuro: l’etimo “evidenza” deriva dal latino “vedere apertamente o manifestamente” (grazie all’uso della particella intensiva “e-”) mentre “indizio” deriva dalla parola latina “indicium”, la cui radice sarebbe “in-dicere”, far sapere, manifestare, che confronta col termine greco “diknýein”, mostrare. Ricordiamo che in latino “monstro” deriva della radice “mon-” da dove si ottiene anche il verbo “moneo”, avvertire. Uno dei padri della semiotica, Émile Benveniste, ci mostrò che la radice di mostrare si ritrova ugualmente nel giudice, dal latino “iu-dex”, dove “dex” sarebbe la radice “deik”, dire in greco. E dunque possiamo affermare che mostrare significa mostrare dal discorso. Ma anche, seguendo l’analisi di Benveniste, prescrivere la norma, mostrare il retto, cioè il corretto. La regola è quello che è stato detto, e l’indizio è l’indicazione dei fatti, quello che è stato detto sui fatti: la giustizia nel mondo greco, la díkê, si trova nelle “formule che regolano la sorte”, e da lì i veri e falsi presagi (il dire vero o falso dai dei) riportati da Cicerone —presagium come adagium si collegano alla radice latina aio “dire”. Ma anche i monstri, dal latino monstrum orrendum. (Collin Powell può servire come esempio di falso presagio...)
Quindi esiste una notoria differenza etimologica tra “provare” e “mostrare” / “dimostrare”. Da Aristotele la retorica classica ha diviso le prove in intra-discorsive ed extra-discorsive: quelli intra sono le costruzioni e le immagini utilizzate per convincere gli ascoltatori mentre quelli extra sono le prove documentarie o testimoni... Comunque riconoscendo la complessità della comprensione delle riazioni dell’auditorio —lo stesso Aristotele ammette questa incapacità da parte della retorica—, la retorica ha una histoire restreinte, in parole di Genette, cioè si limita all’analisi dei tropo. Dire non è mostrare, dice un famoso aforismo di Wittgenstein... Ma in greco classico “monstro” sarebbe “enargaion”, la cui radice è la stessa di “argos”, aggettivo che significa brillante, luminoso ecc. “Enargaion” sarebbe dunque far brillare dal discorso. Il sospetto per l’appunto è quella figura che si lascia guidare per la messa in scena dei discorsi e per le condizioni in cui si è fatto.
Ovviamente far prova della fedeltà di un politico chiedendo, come ho già accennato prima, a un altro di risponderne è di per sè impossibile —il discorso brilla di menzogna prima di essere prodotto—! È come chiedere una valutazione estetica della nostra bellezza alle nostre madri: il valore della risposta sarà sempre inaffidabile! E quindi dalla politica possiamo attendere discorsi delatori o probatori, ma tutte le prove si faranno dal discorso, utilizzando sempre un serbatoio di figure efficaci, come quelle abbiamo visto nell’esempio di Besson.
Nella situazione cosiddetta normale, “l’individuo non fa caso a ciò di cui gli altri si preoccupano, anche se è lui l’oggetto di quelle attenzioni”; l’evidenza si palesa quindi quando un individuo cerca di decifrare i segnali di avvertimento “dissimulando i suoi sospetti, mentre gli altri dissimulano la minaccia [...] cercando al tempo stesso i segni dei suoi sospetti”, cito da Fabbri. Nella situazione cosiddetta anormale, l’individuo confonderà indizi e prove: nel caso della politica (lo definisco anomalo poichè il rapporto è fondato su un elemento instabile, cioè il sospetto) basato su un complesso labirinto di discorsi interrelazionati costruendo così via un insieme di valori mitico-morali che serviranno dopo per le delazioni ulteriori fra i politici stessi...
Che ci siano piccoli movimenti di contestazione oggi, non vuole dire un’altro che il modello di sospettabilità è un modello instabile: continuando col esempio delle coppie possiamo fare il paragone fra scioperi e manifestazioni dal lato del rapporto politici-cittadini e risse e discussioni dal lato delle coppie. Le risse così come le manifestazioni o scioperi soltanto riaffermanno il sistema già stabilito.
In un mondo come il nostro, in una cultura del shock e della finta novità, tutto ciò che sembra un nuovo cambiamento crea un effetto di sospetto... Ad esempio molti hanno accennato che Obama in realtà non suppone un cambiamento politico poich’è stato educato dai bianchi: io, invece, ritengo che chiamandosi Hussein Barack ed essendo nero —o abbronzato se parliamo in linguaggio scorrettamente politico— soltanto può accadere una tragedia, come dimostrò Shakespeare con Ottello! (Speriamo di no...)
Quindi l’unica evidenza che ci lasciano i politici della loro attività è, seguendo le parole di Besson, la fedeltà rivolta verso loro stessi, un’auto-fedeltà che scopre contemporaneamente una fiducia nei loro atteggiamenti e atti... Ma questo sarebbe un altro argomento da accennare: quello dei discorsi autoreferenziali e il ruolo dell’identità individuale davanti al gruppo dentro della politica. Quindi esiste la possibilità di ritornare ad un momento di passione politica colettiva per fare fronte alla politica attuale?
In ogni caso il ruolo dell’università dev’essere la critica: dobbiamo essere i eretici della società. La nostra responsabilità è continuare la strada fatta per questa nobile istituzione: lottare contro il prestabilito. Forse noi possiamo ricuperare quella passione politica, ma soltanto si potrà fare con un lavoro serio: esaminando ed analizzando la realtà!
martes, 9 de diciembre de 2008
Evidenze e sospetti: regime della politica odierna
Etiquetas:
Claude Lévi-Strauss,
Ludwig Wittgenstein,
Paolo Fabbri,
Umberto Eco
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












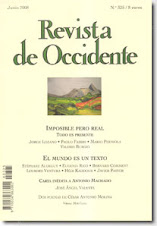



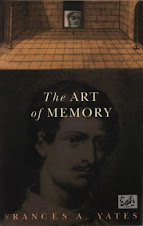







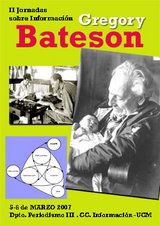

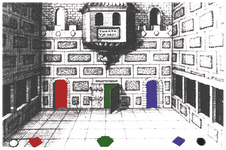
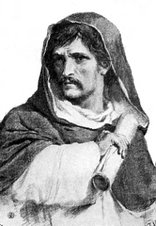
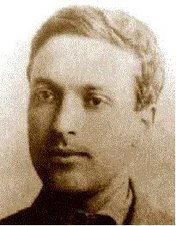


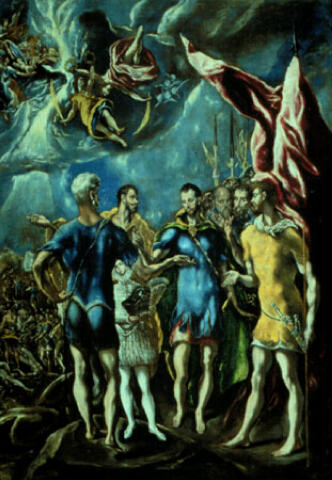

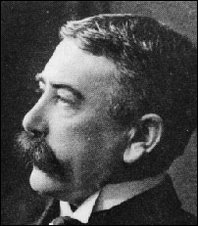

No hay comentarios:
Publicar un comentario