Ad una persona alla quale devo la scoperta della differenza in italiano tra 'melanconia' e 'malinconia', in senso strettamente linguistico-semantico
I’m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there’s a pair of us!
Don’t tell! They’d banish us – you know!
How dreary – to be – Somebody!
EMILY DICKINSON (1861)
Mentre leggevo le lettere di Leopardi, mi son trovato davanti a due visioni diverse della malinconia quasi opposte:
«(…) l’ostinata nera orrenda barbara malinconia che mi lima e mi divora. (…) quella bella malinconia che parturisce le belle cose, pìù dolce che l’allegria».
Quindi, sempre secondo Leopardi, la malinconia può essere un sentimento distruttivo («lima» e «devora») o costruttivo («parturisce le belle cose»). La prima cosa che mi è venuta in mente, è l’immagine di Democrito, dipinto da Albert Dürer, il filosofo per cui gli abitanti di Abdera chiesero a Ippocrate una cura per il suo stato tra malinconia e sorriso. Lo stesso Ippocrate che in uno dei suoi Aforismi scrisse che quando la tristezza ed il timore durano troppo si può parlare di uno stato maliconico. Egli vedeva la maliconia come l’«epilessia della mente»… Seguendo questo paragone, possiamo riaviccinarci alla definizione di Freud: «dolente e profonda depressione, una sospensione dell’interesse per il mondo esterno, la perdita della capacità di amare (…), l’inibizione di ogni singola attività».
Aristotele comincia i suoi Problemata chiedendosi perché i geni soffrono di malinconia, quel sentimento identificato iconograficamente, dai greci, con la Geometria. Essi, tra l’altro, videro in Cronos, come ricorda il Saxl, la raffigurazione simbolica della malinconia. Non è strano quindi che Goya rappresentasse Cronos al confine del mondo durante la notte. Osservando la notte, Zarathustra affermava che essa «è anche un sole». Cronos, figlio di Gea e, secondo Esiodo, padre creatore degli dei Olimpici, è raffigurato da Goya in «una sospensione dell’interesse per il mondo esterno». «Nera orrenda barbara» ma «bella»; triste ma sorridente; dolente ma creatrice delle «belle cose, più dolce che l’allegria», la malinconia si consegna all’uomo che crea.
Sorella della nostalgia, del rimpianto, le mal du pays, homesickness, regret, oggi chiamata, in modo errato, depressione, la malinconia era identifacata dai romantici con la noia, o più esattamente con lo spleen, dal greco splén, o l’Ennui… cito a memoria il testo di Baudelaire: «L’Ennui, l’oeil chargé d’un pleur involontaire, / Il rêve d’echafauds en fumant son houka, / Tu le connais, mon lecteur, ce monstre délicat / Hypochrite lecteur —mon semblable, mon frère». O, come la definisce Flaubert, nel suo Dictionaire des idées reçues: «signe de disntinction du coeur et d’élévation de l’esprit». La malinconia è vista nuovamente in forma di nostalgia, si presenta con l’occhio riempito di un pianto involontario, sognando patiboli mentre fuma la pipa, in somma un mostro creatore (delicato), come distinzione del cuore ed elevazione dello spirito. Marsilio Ficino in “De vita triplici” afferma che il temperamento maliconico porti in sé una profonda ambiguità, perciò, può derivare dal genio come dalla malattia.
Quando Cioran scrive: «la mélancolie est l’état de rêve de l’egoïsme: plus aucun objet en dehors de soi», sembra affermare lo stesso concetto di Groucho Marx: «Non accetterei mai di essere socio di un club dov’io fossi accettato». La sospensione dell’interesse per il mondo esterno si manifesta qua nell’incapacità di osservare gli altri, in un egoismo ironico. L’uomo di oggi è un Amleto senza scopo: «Da poco tempo e senza sapere perché, ho perso la mia allegria». Mentre l’Amleto di Shakespeare affermava di aver visto suo padre «con gli occhi del pensiero» (In my mind’s eye), l’Amleto di oggi ha chiuso i suoi occhi sia al mondo esterno che al mondo interno, ovvero a se stesso. È opportuno ricordare la correzione fatta da Dostoievskij al comandamento biblico «Ama gli altri come te stesso»; l’autore inverte la lettura, cioè, soltanto se si ama se stessi si puó essere capaci di amare quanlcun altro. Tuttavia, questo pensiero è stato malinteso…
Il nuovo malinconico è egoista, capriccioso, vuole l’attenzione degli altri, si sente ammalato e trova piacere nello sguardo pietoso dell’altro. La mancanza, la nostalgia o malinconia provocata da qualcosa che non si possiede più o che è impossibile di possedere, è considerata come una moneta di scambio che ci permette di raggiungere i nostri scopi. La malinconia moderna è risolta in un supermercato o in un ufficio, nella possessione materiale che ci ricorda che possiamo essere soli al mondo ma senza sofferenza… In un certo senso Cioran si sbagliava: gli oggetti ora ci sono, ma sono come fantasmi del mondo interno all’uomo. Ricordando Eric Fromm, posso affermare: «più si possiede, più ci si svuota dell’essere». E questo leitmotiv ci porta a pensare che l’uomo della nostra epoca ha confuso sia materia e spirito (o psiche) che, come ho accenato prima, malinconia e depressione. O come diceva Georg Simmel sull’uomo ‘libero’ della metrópoli del ‘900:
«Il riserbo e l’indifferenza reciproci —i presupposti spirituali delle cerchie più ampie— non sono mai avvertiti più fortemente nei loro effetti sull’indipendenza dell’individuo che nella più densa confusione della metrópoli, dove la vicinanza e la angustia dei corpi rendono più sensibile la distanza psichica. Ed è solo l’altra faccia di questa libertà il fatto che a volte non ci si senta da nessuna parte così soli e così abbandonati come nel brulichìo della metropoli: qui come altrove, non è detto affatto che la libertà dell’uomo si debba manifestare come un sentimento di benessere nella sua vita affettiva».
Per questo motivo, tante storie della letteratura e del cinema moderni raffigurano la malinconia nel bambino, personaggio innocente sprovvisto ancora dell’ansia di possedere. Dal Tom Sawyer di Mark Twain, la Storia infinita di Michael Ende o la dolce malinconia dell’Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, fino alle storie neorealiste di Vittorio De Sica (Ladri di biciclette) o di Roberto Rossellini (Germania anno zero) o della nouvelle vague, nella quale troviamo il chiaro esempio di François Truffaut (400 coups). I bambini, in ognuna di queste storie, osservano con occhi malinconici l’impotenza dell’uomo nel conquistare la felicità, sempre legata alla possessione.
Ladri di biciclette tiene conto di questa idea: la società costringe il protagonista ad avere una bicicletta per poter lavorare. Impegnando alcune sue proprietà (sei lenzuola) riesce ad averla. Suo figlio, il suo Sancio Panza, osserva le disgrazie che il padre é costretto ad affrontare: il primo giorno di lavoro, gli rubano la bicicletta, non riuscendo a ritrovarla é obbligato a rubarne un’altra. «L’occhio pieno di un pianto involontario» del bambino è un occhio malinconico. Non è l’occhio di Eraclito, che piange per la miseria dell’uomo; bensì l’occhio di Democrito, sorridente e malinconico, che osserva l’assurdità dell’uomo. Durante lo stesso giorno, il bambino, contemporaneamente, mangia accanto ad una famiglia di ricchi e si imbatte nella caduta morale del suo modello. Suo padre infatti, viene catturato e malmenato dalla folla per il suo reato, momento in cui il bambino scoppia in lacrime. Lo stato di sogno malinconico del bambino non è egoísta, giacché piange per suo padre. L’oggetto desiderato non gli importa più. La mano che il figlio dà al padre, alla fine del film, é il simbolo della consapevolezza che non possedere una bicicletta non esclude affatto la felicità. La mano del bambino è la stessa mano che porta Charles Chaplin e la sua compagna verso l’orizzonte lontano, nel mezzo del deserto, in Tempi moderni: la malinconia innocente ed infantile di Chaplin è ancora presente nella figura del bambino di Ladri di biciclette.
La mia interpretazione del messaggio di De Sica è che: soltanto il bambino può mantenere la malinconia primitiva dell’uomo. Gli uomini sembrano troppo coinvolti nell’acquisizione di beni materiali per comprendere la differenza tra la depressione (lo stato emozionale distruttivo) e la malinconia (stato emozionale allo stesso tempo distruttivo e costruttivo).
Il sorriso tetro del pagliaccio di McDonald, ad esempio, ci ricorda quanto è diventato capriccioso l’uomo moderno: acquistando un Happy Meal avrai una sorpresa, cioè una nuova possessione. Ma l’idea stessa di sapere ed aspettarsi una sorpresa è un paradosso. La speranza rimasta nel vaso di Pandora fa riferimento alla molteplicità di possibilità impreviste della vita. L’ Happy Meal rende il cliente oracolo di se stesso: «ci sarà una sorpresa». Come nel caso dei giochi, le cui istruzioni limitano già le possibilità di uso della gioco stesso (R. Barthes), la consapevolezza del luogo dove possiamo trovare la sorpresa (così come il cibo, una sauna turca, un film action ecc.) ci fa dimenticare che alla fine l’Ordine perfetto non esiste e, soprattutto, che nell’Ordine perfetto la sorpresa, l’imprevisto, non è neanche possibile: l’Happy Meal è il simbolo di una felicità mancata. Facciamo grande fatica a capire il bambino del dopo guerra di De Sica, é un bambino di un tempo troppo lontano per noi. La sua malinconia è un processo d’interazione con un mondo particolare, un mondo sottomesso al rigore dell’ imprevisto. Noi, invece, viviamo nella mappa che abbiamo creato del mondo reale, per non subire le inclemenze del Desordine. Partendo di questo principio, la crisi economica sembra un’errore di conessione della Google Map.
Nel film di cui parlo, l’imprevisto viene raffigurato nella ricerca della bicicletta effettuata dal padre. Di tanto in tanto, lo spettatore si confronta con un momento di sorpresa: non si sa mai se troverà la bicicletta. La speranza é in lotta constante con la disperazione. Se il film finisse con il grido disperato del bambino (Papà!), il senso tragico riempirebbe tutta la storia, come succede con le morti di Aiace o di Don Chisciote, finalmente consapevoli dei loro atti precedenti. La mano del bambino che da sostegno a suo padre ha un dolce aroma di speranza... È lo stesso stato di sogno malinconico di cui sembra parlare Cioran, nel quale l’uomo non ha più interesse per gli oggetti che ci sono intorno. Il bambino che, durante il film, non fa altro che guardare attentamente suo padre, si fonde con il padre in un solo essere.
Paradossalmente, il bambino —l’essere egoista per eccelenza— è l’unica raffigurazione possibile della malinconia nella nostra cultura: è il Cronos malinconico dei greci. Gli adulti sono troppo legati alla ricerca di possessioni esterne per poter accedere a un tale sentimento. Nella mano di quel bambino si concentra la sentenza di Zarathustra, «la notte è anche un sole», cioè la speranza rimasta del giorno. Perché non c’è speranza che non sia la traccia di una frustrazione, come non c’è frustrazione che non sia la traccia di una speranza mancata: non c’è giorno che non sia la traccia di una notte precedente e viceversa.
Dal mio punto di vista, il sorriso del Democrito malinconico è la traccia della speranza, come nel bambino di De Sica la sua mano abbracciata a quella di suo padre. La malinconia prevede un’intensa sensibilità verso il mondo. Eraclito è l’uomo che piange la miseria essenziale dell’uomo. Democrito sorride perché vede nella miseria la possibilità che l’uomo sia ancora l’uomo. L’intensità malinconica di Democrito gli permette di percepire l’indivisibile binomio miseria-uomo.
Travestendo la malinconia da depressione, Freud intuiva già una nuova percezione del mondo: la bella malinconia che partorisce le belle cose, secondo Leopardi, non è più possibile in un mondo dove la creazione si confonde con la produzione e dove le belle cose si confondono con le finte sorprese.
Davanti alla frase «un mondo migliore è possibile», il malinconico non piange per i miseri uomini che non hano da mangiare; il malinconico sorride democritianamente, consapevole del fatto che chi lo dice rappresenta l’uomo occidentale che ha creato quella mancanza e crede che il suo stato in possesso possa servire da modello. Ma l’uomo occidentale ha chiuso gli occhi al mondo esterno come al mondo interno.
L’uomo che sono ha sofferto di crisi di gioia e di malinconia. È il prezzo che si deve pagare per poter vivere la sorpresa del vivere. La notte è anche un sole, il pianto è anche un sorriso. La gioia assoluta è propria dell’ infelice, dell’ idiota o del depresso. La vera sorpresa è quella del naufrago che, arrivando alla spiaggia, non capisce ancora come è riuscito a salvarsi (Blumenberg). La mano del bambino di De Sica non è un segno di disperazione per la bicicletta non ritrovata, ma un segno di gioia malinconica provocata per la sorpresa di vedere suo padre salvato da una fine tragica: è una malinconia che è più dolce dell’allegria.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












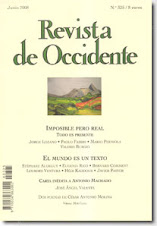



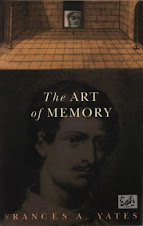







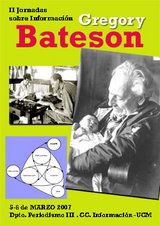

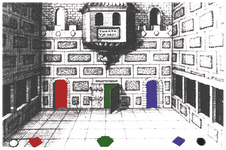
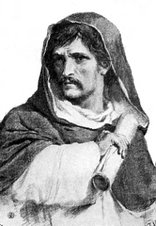
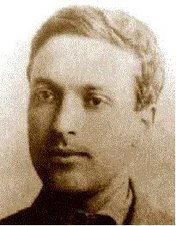


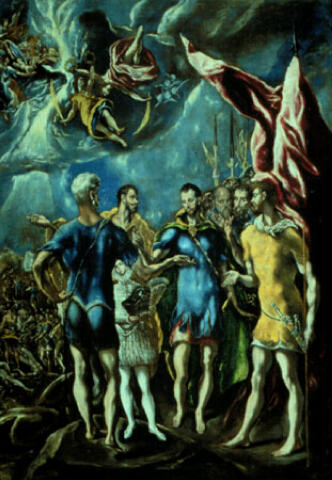

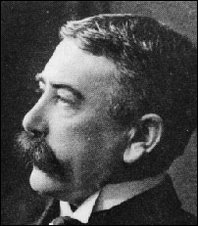

No hay comentarios:
Publicar un comentario